Avendo esaminato la fattispecie sotto il profilo legale, anticipo alcuni aspetti da avere presente, essendo la guida un’opera particolare, in cui il testo è una raccolta di informazioni/interviste eseguite da incaricati (i giornalisti) su esercizi commerciali e non un diretto scritto. 1.- Non riterrei però trattarsi di opera collettiva, nel qual caso, la legge sul diritto d’autore n. 633/1941 stabilisce all’art. 7 che è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. È anche opportuno che sia stato chiarito non trattarsi di un’opera commissionata dall’editore perché altrimenti il committente avrebbe avuto diritto alle riedizioni, in quanto il committente acquista la proprietà dell’opera. 2.- Il diritto di autore, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, non tutela l’idea in quanto tale, ma la sua rappresentazione formale ed originale che in essa si realizza ai fini della sua comunicazione a terzi. Nella sua accezione minima l’originalità “si identifica, in ultima analisi col requisito di novità in senso oggettivo; vale a dire, con l’attitudine dell’opera a distinguersi da quelle preesistenti” (cfr. A. Mastrorilli, in Foro It., 1994, pag. 2419). La giurisprudenza, pur richiedendo, in linea di principio, un apporto effettivo di creatività, al fine di tutelare l’opera come prodotto dell’ingegno (apporto che spesso si esaurisce nel requisito minimo di non banalità), talvolta si è accontentata di una soglia molto bassa di originalità, che permette di accordare la protezione da diritto d’autore anche ad un catalogo di merci, fino ad operare, in alcuni casi, una sostanziale inversione concettuale per cui l’opera non viene tutelata in quanto originale, ma diventa tale al fine di ricevere tutela. La Suprema Corte in una sentenza (Cass. n. 11953/1993) ha dichiarato che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate nell’art. 1 della L. n. 633/1941. Ne deriva, alla stregua di questa affermazione, che l’opera dell’ingegno riceve protezione quando sussiste un atto creativo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. L’opera deve possedere, anche se non necessariamente in grado elevato, il requisito della creatività, originalità e novità, così da distinguersi quale prodotto singolare della personalità del suo autore (vedi Trib. Bologna, 16 aprile 1997, in Aida 1998, 573). Di conseguenza si è osservato che il comune denominatore posto dalle diverse pronunce a fondamento del copyright non consiste più, in punto di fatto, nel requisito di creatività, così come tradizionalmente inteso. Piuttosto, depurato da implicazioni ideali ed estetiche (secondo le quali sarebbe necessario un apporto intellettuale che rechi in sé, indelebilmente, l’impronta geniale del suo creatore) esso diventa un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore (cfr. Mastrorilli op. cit.). 3.- Ci si deve chiedere se la guida, dal punto di vista del suo contenuto, possa essere qualificata opera compilatoria. Infatti, in genere tali opere sono elaborazioni di materiale già presente nel patrimonio intellettuale della società1. L’opera compilatoria viene annoverata tra gli oggetti del diritto d’autore solo quando presenti un quid novi, quando, cioè, sia il frutto di un’elaborazione personale. Più precisamente, si è ricondotta tale elaborazione all’esercizio della facoltà di scelta, spettante all’autore, tra un numero elevato di alternative possibili (è il caso, ad esempio, della redazione delle voci di un dizionario); si è giunti, pertanto, alla conclusione che “qualora i criteri della compilazione siano puramente meccanici, come ad es. nella raccolta cronologica delle leggi emanate dallo Stato in un determinato periodo”, viene meno qualsivoglia possibilità di scelta e con essa la tutelabilità stessa dell’opera. Secondo il Tribunale di Milano, esaminando il problema della tutelabilità delle c.d. pagine gialle, le opere di compilazione a contenuto prevalentemente informativo possono ricevere protezione sul piano del diritto d’autore, ove esprimano quel minimo livello di creatività necessario a farle assurgere a dignità di opera dell’ingegno. Nelle opere di compilazione il carattere creativo non può che concernere i criteri di selezione, coordinamento e sistemazione dei dati elaborati (cfr. Trib. Milano ord., 10 dicembre 1996, in Aida 1997, 488). La guida in oggetto rappresenta una selezione e non è riproduzione di elenchi preesistenti di esercizi commerciali e presenta il carattere di originalità che discende dal taglio dei negozi di cui si forniscono gli indirizzi e la descrizione; tale originalità è provabile in causa dal materiale che potrà essere fornito circa il paragone con altri tipi di guida. 4.- L’opera è protetta dal diritto di autore nei confronti delle sue imitazioni: il c.d. plagio che può assumere il tipo dell’usurpazione o della contraffazione2. Per aversi plagio non è necessario che sia copiata l’intera opera, ma è sufficiente che la violazione riguardi il nucleo essenziale di essa, nel senso che gli eventuali elementi aggiunti, modificati o soppressi non siano tali da eliminare il legame esistente tra l’opera stessa ed il suo autore (Trib. Monza, 26 maggio 1994). La stessa sentenza continua: “Nella valutazione da compiersi in ordine alla esistenza del plagio, occorre evitare l’errore di conferire allo schema dell’autore analiticità e concretezza sulla base del programma che si assume lesivo del diritto di autore. È invece necessario ragionare come se quest’ultimo non fosse mai stato realizzato e chiedersi se, sulla sola base delle scarne indicazioni dell’autore, sarebbe stato possibile delineare in modo compiuto il progetto che si assume contraffatto” (Trib. Monza, 26 maggio 1994, Riv. dir. ind. 1995, II, 211)3. Ha precisato poi la Suprema Corte (Cass. 10 maggio 1993 n. 5346, Dir. Autore 1994, 70) “che è corretta e non presenta vizi di logica né errori di diritto (e, quindi, è insindacabile in sede di ricorso per cassazione) la considerazione del giudice di merito secondo cui apportare piccole e facili variazioni ad un testo copiato radicalmente non possa porre al riparo l’autore del plagio dalla responsabilità in cui si incorre per aver consapevolmente fatto proprio il grosso del lavoro altrui (nella specie, si erano soppressi, da una pubblicazione di quotazioni e valutazioni del mercato dell’usato delle autovetture, alcuni dati o questi erano stato sostituiti con una loro media statistica)”. “Nell’esame comparativo tra due opere che consistono in una guida alfabetica di una città, occorre tener conto, ai fini di accertare la contraffazione dell’una rispetto all’altra, sia della destinazione sia dei passi o brani riprodotti da un’opera all’altra (nella specie si trattava di due opere, l’una intitolata «Le strade di Bologna», pubblicata in volume, l’altra «I segreti di Bologna», distribuita in fascicoli di otto pagine ciascuno unitamente ad un quotidiano)” (Pret. Bologna, 17 novembre 1992, in Giur. di Merito, 1994, 634)4. 5.- Ciò posto, altro aspetto da considerare è l’art. 4 L. n. 633/1941 che, senza pregiudizio dei diritti d’autore, protegge anche “la esistenza sull’opera originaria di elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali … le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”. È chiaro che nelle guide annuali successive interverranno variazioni nei negozi censiti, anche se non penso che si arrivi al loro mutamento al 100%. Bisogna domandarsi quali conseguenze avrebbe se l’editore volesse sostenere che l’edizione della guida dell’anno successivo fosse una elaborazione, consentita per legge, della guida dell’anno precedente, con il che verrebbe fatto salvo solo il diritto morale di autore, ad essere citato come fonte di ispirazione. Ora l’elaborazione di opere di ingegno preesistenti è protetta, a condizione che abbia carattere di creatività rispetto all’opera originaria, dovendo possedere un grado sia pure minimo, di originalità ed individualità idonee a differenziarla da questa (cfr. Cass. n. 2345/1994). “Le elaborazioni di un’opera originale sono date dalle traduzioni in un’altra lingua, dalle trasformazioni da una in un’altra forma letteraria od artistica, dalle modificazioni ed aggiunte che costituiscano rifacimento sostanziale dell’opera originaria, dagli adattamenti, dalle riduzioni, dai compendi e dalle variazioni che non costituiscano opera originale. Ma se questi sono i «generi» dentro cui la legge riconduce le opere di elaborazioni proteggibili, dei quali peraltro riteniamo che il legislatore abbia voluto compiere un’esposizione esemplificativa e non tassativa, in ogni caso, di fronte alla fattispecie concreta, sarà necessario svolgere un apprezzamento dell’opera in termini di creatività, perché solo quando tale carattere venga riscontrato sarà possibile accordare la tutela che l’ordinamento offre alle opere dell’ingegno. L’opera di elaborazione, qualificata anche come opera derivata, deve essere ispirata all’opera principale, cioè deve trarre da questa spunti ed elementi riconoscibili, ma ciò non basta; l’opera derivata deve essere caratterizzata, a sua volta, da elementi di creatività ed originalità tali da renderla opera dell’intelletto autonoma” (cfr. A. Alessi in Giust. civ. 1995, pag. 1076 e seg.). Riterrei che una edizione dell’anno successivo della guida non abbia natura di elaborazione creativa; questa circostanza è verificabile, tuttavia, esclusivamente dall’esame comparativo che sarebbe eseguibile solo dopo la pubblicazione. 1 Man mano che l’apporto creativo dell’autore si riduce rispetto ai fatti, contenuti nella sua opera, ma preesistenti nella realtà oggettiva (che, per questa ragione, sono sempre meno “idee” e sempre più “dati”), la funzione dell’opera viene naturalmente a modificarsi: essa non consisterà più nella form of expression, ma nella divulgazione, che essa consente, dei dati stessi. Sì che risulta difficile valutare, in questi casi, la prevalenza dell’una o dell’altra componente del valore complessivo dell’opera (cfr. Mastrorilli, op. cit.). 2 “Il plagio di un’opera dell’ingegno può assumere la forma dell’usurpazione o della contraffazione, a seconda che si concreti nell’appropriazione della paternità di un’opera altrui, senza apportarvi alcuna alterazione, o nella pubblicazione, sotto il proprio nome, di un’opera che, pur sembrando in apparenza nuova, in sostanza ricalca un’opera altrui, mascherando l’imitazione con modificazioni di ordine formale” (Trib. Roma, 10 marzo 1961, Dir. Autore 1962, 119). “Il plagio può manifestarsi nella forma dell’imitazione servile, cioè nella pedestre imitazione, oppure nella contraffazione, cioè apportando all’opera, al fine di dissimulare l’imitazione, maliziose alterazioni nei particolari, non sufficienti tuttavia ad escludere l’errore o la confusione, a causa della persistenza di elementi caratteristici dell’opera imitata” (Trib. Padova, 27 novembre 1963, Riv. dir. ind. 1963, II, 213). 3 “Per accertare la contraffazione è necessario tener di mira l’individualità di rappresentazione di un’opera, requisito, questo, desumibile da un giudizio che, valutando tutti gli elementi della stessa opera nell’unità inscindibile in cui li ha fusi l’attività creativa della mente umana, porta a identificare in maniera inconfondibile il valore espressivo cui l’opera, per sua essenza, tende. Si avrà, così, contraffazione quando, malgrado varianti, aggiunte o riduzioni, nell’opera nuova sia riconoscibile l’individualità di rappresentazione di un’opera precedente. Per contro non potrà parlarsi di contraffazione nel caso in cui l’opera nuova riveli una propria individualità attraverso una valutazione sintetica della sua forma espressiva, benché, analizzando singolarmente i suoi elementi, si venga ad acclarare che alcuni di essi costituiscono elementi di altra opera” (Trib. Roma, 10 marzo 1961, ivi 1962, 119; Temi romana 1961, 526). “Il plagio consiste nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui: nel ricalcare, cioè, in modo parassitario quanto da altri ideato e, quindi, espresso in una forma determinata e identificabile” (App. Roma, 16 febbraio 1987, Temi romana 1987, 94). “La personalità creativa dell’autore di un’opera dell’ingegno, più che nella novità dell’idea ispiratrice, si manifesta nell’originale composizione e organizzazione di tutti gli elementi che concorrono a formare l’opera e che, tutti insieme, costituiscono la forma individuale di rappresentazione di quel determinato autore. Pertanto, mentre è lecita l’utilizzazione di singoli elementi dell’opera altrui, costituisce plagio l’illecita usurpazione di tutti gli elementi fondamentali in cui si concretizza la creazione originale” (Pret. Roma, 1 febbraio 1960, Dir. Autore 1961, 377). 4 “Costituisce comportamento illecito ai sensi degli art. 100, 2° comma e 101, L.d.A. - normativa questa che rappresenta una speciale applicazione, nel settore editoriale, dei principi previsti in linea generale dall’art. 2598 c.c. - la riproduzione su di una rivista da parte di editore non autorizzato, di una rubrica, pubblicata da altra rivista, contenente elaborazione di dati frutto di una complessa e dispendiosa rete di rilevamento, di un esame critico e comparativo dei dati tenuto contro delle possibili varianti (ampiezza del mercato, uscita di nuovi modelli, richiesta dei consumatori, previsioni circa le ordinazioni); tale comportamento è censurabile ex art. 101, L.d.A. anche solo per la mancata indicazione della fonte delle informazioni prodotte” (Trib. Milano, 11 giugno 1987, in Giur. dir. ind., 1987, 606).
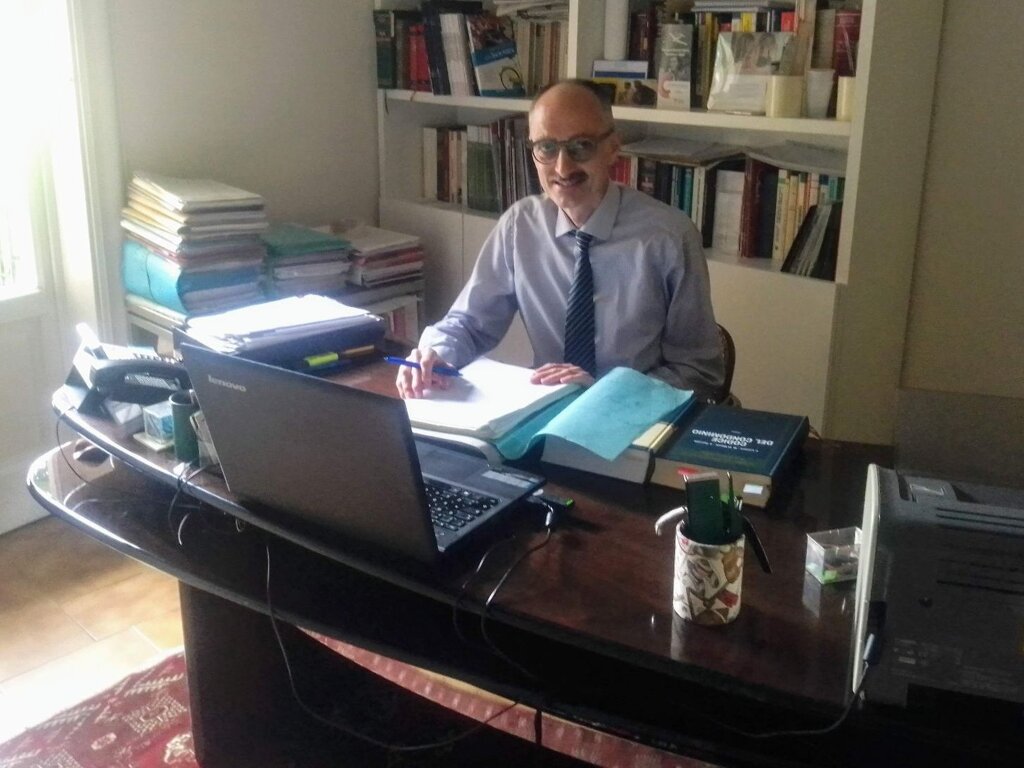
© 2018
Nicola Verri
Ha maturato esperienza prevalentemente nella consulenza alle imprese ed in materia locatizia e condominiale, occupandosi anche di privacy e di compliance aziendale.
Lingue: inglese

Guida ai negozi cittadini e opera protetta dal diritto di autore
Guida ai negozi cittadini e opera protetta dal diritto di autore
2024-09-23 11:25
2024-09-23 11:25
Array() no author 86118
diritto di autore, diritto-autore, guida-turistica, negozi,
© 2018